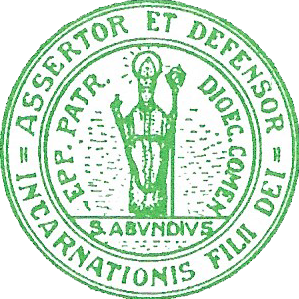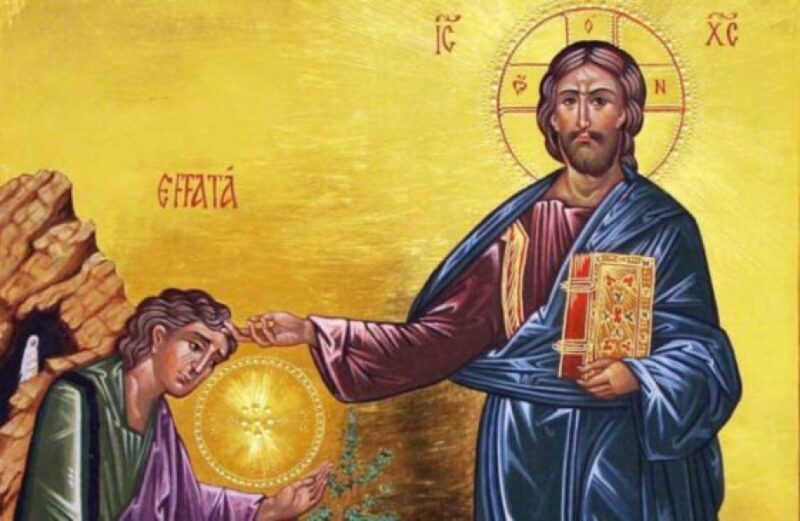XVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO – C
3 Agosto 2025
Fa’ che non ci lasciamo dominare
dalla cupidigia e dall’egoismo,
ma cerchiamo sempre
ciò che vale davanti a te
- Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è la sicurezza. Egli ricerca appassionatamente e necessariamente un fondamento stabile su cui poggiare la propria esistenza. Ora un movimento antico quanto l’uomo è quello di chi sceglie come pietra angolare nella propria vita le cose, il denaro. Il denaro è tutto, si dice. Il denaro è potere. Senza denaro non si può far nulla. Il denaro dà all’uomo il senso della sicurezza, della possibilità di fare tutto. Scatta allora il meccanismo dell’accumulazione: il denaro non è mai troppo, diventa idolatria. Quando il denaro diventa il proprio “dio” (oggi la televisione ci presenta tante di queste situazioni… a cominciare da chi amministra la cosa pubblica ma, di fatto, cura solo i propri interessi!!!), per averlo si è disposti a tutto. La sete del denaro oppone l’uomo all’uomo. Se uno cerca di avere la parte maggiore, l’altro diventa un concorrente da superare o da eliminare. La divisione dell’eredità è sempre stata un momento difficile per le famiglie. Fare le parti giuste è quasi impossibile. La divisione dell’eredità diventa la divisione della famiglia. Il denaro è la sorgente di tutte le gerarchie sociali, di tutte le discriminazioni: chi ha di più è più in alto; gli uomini non sono più uguali, si distinguono per quello che hanno e non per ciò che “sono”!!! E’ così che l’uomo del denaro diventa un uomo “solo”, un uomo alienato, schiavo. Il denaro diventa una prigione. L’uomo del denaro è l’uomo vecchio.
- Il problema della divisione della ricchezza è uno dei più gravi a tutti i livelli. Come interviene Cristo in questa situazione? Perché Cristo rifiuta di farsi giudice fra i due della parabola evangelica odierna? Perché non è la sua missione fare giustizia mediante la via del potere. Il potere si giustifica moralmente quando si mette a servizio della giustizia. Cristo non lo condanna in quanto potere. Solamente che il potere non è la via che egli ha scelto per “fare giustizia”. Cristo, anzitutto, riprende l’insegnamento della saggezza umana, espresso già nell’Antico Testamento, traducendolo nella parabola del ricco insensato (Lc 12,16-21). Le cose sono una falsa sicurezza. Il possesso è in realtà illusorio: il ricco è posseduto dalle cose, ma in fondo non le possiede. La morte rivela in modo evidente questa verità. La meditazione della morte compie nell’uomo la liberazione da un’illusione, una prima liberazione dalle cose. Non è però una meditazione di tipo moralistico. Gesù non vuole inculcare nei suoi ascoltatori abbienti il timore di una morte improvvisa e individuale che manderebbe in fumo le loro speranze. In realtà la visione che si ha qui della morte è escatologica ed è collegata col giudizio di Dio. Il fondamento sicuro dell’esistenza è Dio solo. In lui acquista significato anche l’uso delle cose, in sé buone. Non saranno più strumento di divisione, ma di comunione. L’uomo non le tiene egoisticamente per sé, ma le trasforma in “segno” d’amore. «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene, all’uso di tutti gli uomini e popoli, così che i beni creati debbono essere partecipati, secondo un equo criterio, a tutti, avendo come guida la giustizia e compagna la carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli, in vista delle diverse e mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa destinazione universale dei beni» (GS 69).
- «Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco» (Ap 2,9): così lo Spirito “esalta” la Chiesa di Smirne. Alla Chiesa di Laodicea, invece, rinfaccia: «Tu dici: “Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla”, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo» (Ap 3,17). Il giudizio dello Spirito — si legge nel Catechismo degli adulti (pagg. 183-184) — riporta in primo piano l’insegnamento della croce. La Chiesa è “ricca” quando, materialmente povera di risorse, è pronta a ricevere nella fede quelle risorse che provengono dallo Spirito di Cristo, suo Capo e Signore. È in realtà “povera”, cioè “infelice, miserabile, cieca e nuda“, quando più che nello Spirito, confida nei mezzi umani di cui dispone. La Chiesa influisce sul potere, ma ne viene contemporaneamente influenzata, a volte strumentalizzata. E non mancano le voci che denunziano il pericolo che la minaccia. «Combattiamo contro un persecutore insidioso — scrive sant’Ilario di Poitiers nel IV secolo — un nemico che lusinga… non ferisce la schiena ma carezza il ventre; non confisca i beni per darci la vita, ma arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà imprigionandoci, ma verso la schiavitù onorandoci nel suo palazzo; non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore».
- L’esortazione paolina a «cercare le cose di lassù» esprime un riorientamento dell’esistenza attraverso una dialettica-conversione tra il celeste e il terrestre, il visibile e il nascosto, tra il vecchio e il nuovo, tra le diversità umane e l’unità in Cristo. La risurrezione di Cristo è un totale riorientamento della storia, del mondo, di ogni esistenza e tale “punto di vista” costituisce il criterio per valutare ogni cosa e per agire di conseguenza. Nel testo paolino, infatti, emerge sia un contrasto che una tensione, sia una dialettica che una compresenza; si tratta di guardare le cose di sempre con occhi diversi e questi, comunque, non cambiano il volto della realtà, ma le danno un orientamento differente. Le «cose di quaggiù» sono importanti, ma vanno viste insieme a «quelle di lassù».
- La nostra vita è reale e preziosa, ma la “vera” vita è «nascosta con Cristo in Dio!». Quindi c’è un di più di cui essere consapevoli e che porta a un modo diverso di vivere. Al centro di «ciò che appartiene alla terra» c’è «quella cupidigia che è idolatria». Questa affermazione è quella che giudica da un punto di vista teologico le «cose della terra», poiché denuncia il rischio di una sostituzione di Dio con qualcos’altro (idolatria). L’avarizia-cupidigia (pleonexía) viene definita idolatria, quindi interpretata in chiave religiosa. Il bastare a sé stessi, l’illusione dell’autosufficienza sono dunque l’idolatria più grande (se non l’essenza stessa dell’idolatria) che descrive l’uomo “non risorto”, “vecchio”, imprigionato, impermeabile al dono di Cristo che invece, se accolto, «è tutto e in tutti». Occorre guarire l’idolatria dell’io, attraverso la condivisione, in cui viene infranta ogni autosufficienza, ogni illusione di poter disporre totalmente della propria vita attraverso il possesso.
- È opportuno ribadire che il problema oggi è l’incapacità di condividere, non il fatto di possedere. Non si tratta di contestare la proprietà privata oppure l’essere abbienti e benestanti, ma il fatto che «anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». La sentenza evangelica è di una trasparenza cristallina e il suo sviluppo narrativo descrive proprio il ripiegamento egoistico su sé stessi che dimentica totalmente gli altri.
TESTI E MATERIALI
RITI DI INTRODUZIONE E DI CONCLUSIONE
** Riti di Introduzione con Atto penitenziale XVIII TO C Riti di introduzione
** Riti di conclusione XVIII TO C Riti di conclusione
SALMO RESPONSORIALE
** prima proposta, da Psallite
partitura Salmo XVIII TO C Psallite
audio
** seconda proposta, da Lodate Dio (Nuovo Lezionario) Salmo XVIII TO C LD NL
** terza proposta, dal m° Impagliatelli
partitura Salmo XVIII TO C Impagliatelli
audio
** quarta proposta, da Lodate Dio (precedente Lezionario) Salmo XVIII TO C LD VL
PREGHIERA DEI FEDELI
** prima proposta XVIII TO C Pdf 1
** seconda proposta XVIII TO C Pdf 2
** terza proposta XVIII TO C Pdf 3
** da Orazionale CEI Pdf TO XVIII OR CEI