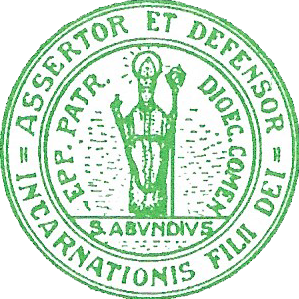VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C
Vivere secondo lo spirito delle beatitudini
- La nostra unica speranza di completa felicità e di salvezza eterna è solo nel Signore. La Liturgia odierna ci ammonisce e ci sprona a vivere come Gesù ha vissuto, senza falsi idoli e vane sicurezze. Non è fuga dal mondo o disimpegno, ma è invito a vivere “in novità” il tempo che ci è donato, in unione con Cristo, nella continua ricerca di condizioni di vita più umane. Le beatitudini indicano una vita vissuta nella libertà da ogni egoismo, per potersi occupare solo del Regno di Dio.
- Da questa Domenica, la Liturgia festiva ci propone la lettura e la meditazione di quel discorso evangelico che costituisce il programma della morale secondo Cristo, la proposta esistenziale di Gesù. Un discorso cruciale, che Matteo chiama della montagna – per assimilarlo ai discorsi di Mosè rivolti a Israele sul monte Sinai –, e che, invece, Luca chiama della pianura, perché la pianura si presta meglio all’impresa dell’evangelizzazione, cioè alla corsa del Vangelo sino agli ultimi confini della terra, perché questa è l’impostazione dei due libri scritti da Luca, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli: il viaggio di Cristo verso Gerusalemme, il viaggio dei discepoli di Cristo da Gerusalemme verso il mondo. Siamo chiamati come Chiesa a disporci tanto all’ascolto amorevole di quanto il Signore proclama, sia che collimi con i nostri gusti e desideri, sia che li contrasti; quanto alla sequela, da discepoli, agli insegnamenti di un Maestro tanto speciale. Le beatitudini ed i “guai” proclamati dal Signore, e che caratterizzano questa Domenica, delineano una sorta di carta di identità del cristiano, nel quale è necessario specchiarsi e misurarsi, per convertirsi.
- Nella Bibbia le cose vanno diversamente. La formula classica della legge morale nell’Antico Testamento incomincia così: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2-3). Fissa, poi, i precetti morali: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, ecc. Si inizia con una dichiarazione di fatti storici, visti alla luce della fede. I fatti si riferiscono alla liberazione del popolo dalla schiavitù e al suo costituirsi come libera nazione. I comandamenti sono il corollario di avvenimenti. Nel Nuovo Testamento l’impostazione è analoga: l’insegnamento morale è connesso con l’annuncio del Vangelo. Ma vi è un fatto, un evento storico preciso da cui deriva l’impegno morale.
- Le beatitudini (Vangelo) esprimono il capovolgimento radicale dei valori che l’evento-Gesù ha realizzato. Sono il “segno” dell’evento. Con esse Luca proclama l’avveramento delle promesse messianiche («Beati i poveri»: Is 61,1ss; Lc 4,18-19.21; 7,22; 10,21ss. «Beati voi che ora avete fame…»: Is 25,6; Lc 22,16-30. «Beati voi che ora piangete…»: Is 35,10; Lc 2,25). In questi poveri e nei perseguitati Luca vede la Chiesa in cui vive (At 14,12; Lc 11,49ss; 12,4-7.51ss; 21,12-19; 22,35-38). Chi dice di sì all’evento-Gesù prova la gioia di sentirsi amato da Dio e inserito nella Storia della Salvezza, partecipando alla sorte dei profeti e di Gesù. I quattro “guai” presentano la sorte opposta di chi dice di no, di chi non crede al Vangelo e, perciò, non si inserisce nella storia salvifica. Le beatitudini non sono separabili dalla persona che le ha pronunciate. Gesù è l’Uomo delle beatitudini. Solo perché lui è risorto (Seconda Lettura) è vero che sono beati i poveri e la nostra fede non è vana (1 Cor 15).
- Le beatitudini non sono “legge”, bensì “Vangelo”, “buona Novella”! La legge affida l’uomo alle proprie forze e lo incita ad adeguarsi fino all’estremo. Il Vangelo, invece, pone l’uomo di fronte al dono di Dio e lo incita a fare di tale, inesprimibile dono, il fondamento della vita. In una civiltà di profitto, in cui il denaro è l’idolo a cui si sacrifica l’uomo e ogni altro valore, in un mondo superindustrializzato e superassicurato, in cui non c’è più spazio per l’autentica libertà, solamente l’Uomo delle beatitudini, l’uomo libero dalle cose, può far riscoprire il vero volto dell’uomo.
- Beati! Benedetto colui che fa il bene, maledetto colui che fa il male; benedizioni ed elogi, biasimi e maledizioni sono realtà alle quali non è possibile sottrarsi con facilità. Ma le “beatitudini” evangeliche non riguardano il futuro del cristiano, bensì il presente della sua esistenza e richiedono un atteggiamento di sequela. Sono provocazioni forti e sconcertanti che non rappresentano o ammettono o canonizzano nessuna rassegnazione storica. Al massimo, la condizione attuale, vista con occhi “sapienziali”, è riconosciuta come “beata”. La differenza tra il testo lucano (6,17.20-26) e quello di Matteo (5,1-12) è nota e qualsiasi commento esegetico chiarifica a sufficienza le diversità. È fondamentale prima di impostare il proprio intervento omiletico prenderne atto per non incorrere in affermazioni che sono prive di fondatezza biblica. Le beatitudini sono, dunque, sollecitazione a non sottrarsi all’impegno della solidarietà e dell’amore evangelico, a coniugare giustizia e carità nell’impegno sociale, a esprimere amore preferenziale per i poveri nelle opere di misericordia corporale e spirituale, a nutrire del Vangelo della carità una nuova coscienza socio-politica, a operare nell’orizzonte planetario della solidarietà, della pace e della salvaguardia del creato.
- Cristo rimane il termine ultimo del confronto, il punto di riferimento per stabilire il bene e il male: egli, il maledetto sulla croce, è il benedetto del Padre. In questo difficile ed esigente itinerario egli ci associa a sé. Ma l’uomo rimane tentato di rimuovere Cristo per collocare sé al centro della storia. Qui la maledizione e la benedizione si invertono. Ci sia di aiuto per comprendere e decifrare dove sta bene e male l’acuta osservazione di P. Giulio Bevilacqua: «Ogni qualvolta alla trascendenza di Cristo si sono sostituite trascendenze astratte: la razza, la classe incarnata in manipoli di narcotizzati di efficienza, l’uomo è stato cancellato nella sua originalità, nella sua fisionomia storica, nella sua autonomia, nella sua libertà di adorare, di pensare, di esprimersi, perfino di muoversi di professione in professione, di paese in paese; così milioni di essere umani (razze intere, intere repubbliche) sono stati traditi, torturati, bruciati, gasati».
- Le beatitudini nel pensiero di Luca sono una “teofania”, la rivelazione del volto e del cuore di Dio. Esse introducono alla vera conoscenza del Padre sviluppando una teologia storico-salvifica. Solo attraverso Gesù di Nazareth e la sua testimonianza, noi abbiamo avuto accesso a questa eccezionale rivelazione. Le beatitudini rivelano anche il cuore e il volto di Gesù, diventato così una “Cristofania”. È da rilevare che questo messaggio di consolazione e di speranza, fruttifica nella misura che deposita nell’uomo il volto nuovo di Dio. Nel medesimo istante esso provoca un cambiamento di vita che non sarebbe stato possibile senza la presenza di Cristo, sacramento del Padre.
- In questa Domenica risuonano frequentemente le parole “benedizione” e “maledizione”, realtà che possono venire da Dio, ma, il più delle volte provengono dalle scelte umane. Tutta la celebrazione annunci e inviti alla benedizione.
- Il Salmo oggi deve essere valorizzato al massimo con una proclamazione in canto dignitosa e convinta. La comunità deve essere invitata ad un ascolto meditativo e ad un’accoglienza nella vita. Esso esprime e sintetizza al massimo la Parola di Dio odierna. Nella legge che medita giorno e notte, l’uomo ritrova la sorgente di ogni vera beatitudine.
- La processione dei doni potrebbe essere aperta alle necessità dei poveri e significare, nel gesto della preparazione della mensa dell’altare, l’invito dei poveri alla mensa di Dio che sazia la nostra fame e cambia il pianto in gioia.
- Il tema evangelico odierno potrebbe essere richiamato al momento della raccolta delle offerte e della presentazione dei doni: il “sovvenire alle necessità della Chiesa e dei più poveri” è un gesto concreto che si attua nella celebrazione.
TESTI E MATERIALI
RITI DI INTRODUZIONE E DI CONCLUSIONE
** Riti di Introduzione con Atto penitenziale VI TO C Riti introduzione
** Riti di conclusione VI TO C Riti conclusione
SALMO RESPONSORIALE
** prima proposta, da Psallite
partitura salmoresp-Cto06-Pantaleo
audio
** seconda proposta, da Lodate Dio Salmo VI TO C LD
** terza proposta, dal m° Impagliatelli
partitura file-tempo-ordinario-vi-domenica-anno-c
audio
PREGHIERA DEI FEDELI
** prima proposta VI TO C PDf 1
** seconda proposta VI TO C PDf 2
** terza proposta VI TO C Pdf 3
** da Orazionale CEI Pdf TO VI OR CEI