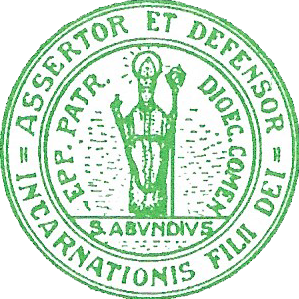XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C
«Il mio aiuto viene dal Signore»
99 Giornata Missionaria Mondiale
19 Ottobre 2025
- Oggi la Chiesa è tutta protesa e invitata alla missione, all’annuncio della fede con gioia e coraggio. Essa è forte della Scrittura che le è stata consegnata, utile per insegnare, convincere, correggere ed educare (Seconda Lettura), ma sa anche che la forza del seme non è sua e che il terreno non dipende da lei… allora ascolta il Maestro che la invita a pregare, insistentemente.
- La Chiesa sa che il popolo vince se c’è uno che tiene levate le braccia al cielo (Prima Lettura). Per lei è Gesù che sta dinanzi al Padre ad intercedere per noi (cfr. Eb 7,25) e lo Spirito che supplica con gemiti inesprimibili; loro sanno cosa sia conveniente domandare. Per grazia la Chiesa è ammessa alla loro preghiera perché anche la sua sia secondo Dio ed efficace (cfr. Costituzione apostolica Laudis canticum per la Liturgia delle Ore, nn 6-8). Pregare è dono! La preghiera sortisce questo effetto: non modifica il pensiero di Dio che sempre e già vuole il bene per noi, cambia noi e ci fa capaci di aderire e volere ciò che Egli ha pensato come bene per noi. Il risultato della preghiera è noi cambiati dalla preghiera e allora accadono meraviglie. Trovi il Signore la fede, questa fede, sulla terra quando verrà!
- La preghiera occupa un posto importante nella vita di ogni cristiano e di ogni Comunità che voglia comprendersi come “Chiesa di Cristo”. S’intende, ovviamente, la “preghiera cristiana”, in quanto nasce dalla fede in Gesù Cristo e in lui trova anche il modello per rivolgerci al Padre: in questo senso è preghiera “ricevuta dal Signore”. Essa [la preghiera] ci inserisce nell’oggi di Dio, quale si è rivelato nella persona e nella vita di Gesù. Essa diventa in-vocazione, poiché situa noi e la nostra storia, personale e comunitaria, davanti a Dio e da lui attende luce e guida, attende la risposta che ci salva.
- Il tempo dell’attesa dell’ultima venuta di Cristo è il tempo della fede e della preghiera. «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8). C’è una circolarità tra fede e preghiera. Se è vero che per pregare bisogna credere è anche vero che per credere bisogna pregare. La preghiera perseverante è espressione e nutrimento della fede in Dio. «Una via privilegiata per recuperare la dimensione più autentica della propria vita è costituita dal tempo dedicato alla preghiera. Pregare è stabilire un dialogo intimo con Dio e con noi stessi; è ascoltare una parola “per noi” che ci trasforma; è immettere, nella nostra vita la forza di rinnovamento dello Spirito» (CdA, pag. 389).
- La preghiera cristiana prima che parola implorante è silenzio profondo per ascoltare e accogliere in sé la Parola di Dio. Le persone entrano in comunione ascoltandosi. Noi entriamo in comunione con Dio e ci disponiamo a fare la sua volontà ascoltandolo. Come la fede, anche la preghiera nasce dall’ascolto: è una risposta vitale, ma anche verbale. Questa assumerà varie forme: un’azione di grazie, una contemplazione piena di ammirazione, una professione di fede, una dichiarazione di impegno, una domanda. Anche la preghiera di domanda è una risposta all’invito di Cristo a «pregare sempre, senza stancarsi» (Lc 18,1). Ma qual è il significato della preghiera di domanda? Non è certamente quello di pretendere che egli faccia al nostro posto quello che dovremmo fare noi. La preghiera di domanda è riconoscere il limite della condizione umana, è constatare che la liberazione totale e la piena realizzazione di sé non dipendono unicamente dall’uomo. L’uomo non può salvare sé stesso. Manifestare a Dio “tutti” i propri bisogni e desideri è sottoporli alla sua luce, è vedere se sono legittimi o no. L’uomo è veramente ciò che domanda; le richieste gli vengono spontanee: dirle a Dio è vagliarle e purificarle.
- La preghiera di domanda è segno di fiducia in Dio. Quando siamo certi che una persona ci vuole veramente bene, con spontaneità le chiediamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che è buono. L’evangelista Giovanni definisce la fede come «credere all’amore di Dio per noi». Ebbene, il credente ha una fiducia così grande nel suo Dio, che a lui domanda tutto con semplicità e a lui si rimette. La parabola del giudice iniquo e della vedova ostinata richiama la necessità di pregare senza disarmare, anche se il Signore tarda e sembra sordo a tutte le nostre suppliche. L’argomento di Gesù è semplice: se un giudice iniquo finisce per darla vinta alla vedova, quanto più Dio che è giusto ascolterà il nostro grido d’aiuto.
- La preghiera cristiana non è una richiesta di intervento immediato di Dio, non è una formula magica che risolve i problemi, ma aderisce ed accetta la libertà e la pazienza di Dio. Altrove, nel vangelo di Luca, Gesù ci dice che Dio ci darà non tanto quello che chiediamo, ma lo Spirito Santo per comprendere il significato di quello che ci capita e per essere suoi testimoni: «Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!» (Lc 11,13). La preghiera di domanda “esemplare” è quella di Gesù nel Getsemani: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42). Il credente, quello autentico, non vuole “piegare” Dio a fare la propria volontà, utilizzarlo per compiere i propri desideri, ma ottenere la grazia di conformare la propria volontà alla sua. Lui solo sa ciò che è veramente nostro bene. La preghiera di domanda, quando è autentica, è sorgente di impegno per cominciare a fare quello che chiediamo. Pregare per la pace, spinge ad impegnarci per la pace; pregare perché cessino le sofferenze, spinge ad aiutare chi soffre… Per questo non deresponsabilizza mai l’uomo, anzi lo responsabilizza maggiormente. «Chi prega si fa prima di tutto attento alla parola di Dio, per rendersi disponibile nella fede ad accogliere la chiamata che viene da lui. Manifesta al tempo stesso la speranza nel futuro di Dio che la preghiera in qualche modo anticipa e promuove. Dà anche una testimonianza di carità tanto è stretto il legame che unisce colui che prega a Dio. Partecipa, infine, alla vita del mondo, perché si sente impegnato in tutto ciò che fa venire il Regno. In tal modo la preghiera è l’atto più significativo del vivere cristiano» (CdA, pag. 392).
- La Liturgia odierna, ancora una volta, ci pone davanti ad una questione importante: quale posto, quanto tempo riserviamo alla preghiera nella nostra esistenza? E, soprattutto, che cosa la caratterizza, quale ne è la “qualità”? C’è una tentazione, sempre in agguato: «Dio mi ascolta? E allora perché non interviene?». E’ la domanda che si pone Israele quando ha l’impressione che Dio resti inattivo: «Svegliati! Perché dormi, Signore? Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? La nostra gola è immersa nella polvere, il nostro ventre è incollato al suolo. Alzati, vieni in nostro aiuto!» (Sal 44,24-27). La risposta la troviamo nel Salmo responsoriale di questa Domenica: «Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra» (Sal 120,3-6).
- Alla tentazione appena evocata sono sottoposte anche le Comunità cristiane dell’epoca di Luca, afferrate da un senso di delusione perché non vedono compiersi le promesse di Gesù, realizzarsi il Regno di Dio. E’ la nostra tentazione, dopo duemila anni di cristianesimo, perché non ravvisiamo in questo mondo il Regno di giustizia, di pace e di amore che ci è stato annunciato. La Liturgia della Parola disegna davanti a noi un percorso: ci presenta, innanzitutto, la forza della preghiera: «Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva» (Prima Lettura); ci invita a riconoscere la bontà di Dio che “non abbassa le braccia” e ci accompagna in ogni istante della nostra vita: «Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra» (Salmo responsoriale); ci chiede la stessa perseveranza della vedova che continua ad insistere presso il giudice finché non trova giustizia: «E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui?» (Vangelo); ci indica il sostegno di ogni preghiera, ovvero quelle Sacre Scritture in cui possiamo intendere la Parola di Dio «utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia» (Seconda Lettura).
- “Pregare sempre senza stancarsi” non significa moltiplicare le parole. Anzi, quando Gesù propose ai suoi discepoli il modello di ogni preghiera cristiana fece questa premessa: «Pregando non sprecate parole come i pagani i quali credono di venire ascoltati a forza di parole» (Mt 6,7). Pertanto, quel “sempre”, usato da Gesù, si riferisce piuttosto ad un atteggiamento interiore di vita che porta a compiere ogni cosa alla presenza di Dio, agendo con verità e giustizia. Pregare non è, in primo luogo, una questione di formule, ma di umiltà davanti a Dio, di consapevolezza dei nostri limiti, di fiducia in Colui senza il quale non possiamo fare nulla.
- I cristiani sono chiamati dal Signore a santificare il “settimo giorno” che egli stesso benedisse e consacrò fin dalla creazione. Un cristiano non può esistere senza la Domenica e questa non può essere celebrata senza cristiani. Nella testimonianza dei martiri di Abitene troviamo queste parole: «Non sai, Satana, che il cristiano è necessariamente legato al Dominicum e questo a lui, e l’uno non può esistere senza l’altro?». Vivere il Giorno del Signore vuol dire avere anche la possibilità di condividere l’esperienza delle meraviglie che egli compie nella vita dei credenti che formano l’assemblea liturgica. Essi sono chiamati a una partecipazione attiva, con il canto che esprime le gioie o le prove, proponendo le intenzioni di preghiera, ascoltando i passi della Scrittura che illuminano e confortano il cammino quotidiano.
- Le assemblee liturgiche devono soprattutto essere costituite da persone vive che sentono e vibrano per quello che fanno e per quello che dicono, non persone passive o spettatrici, per le quali il tempo della celebrazione non è che una parentesi che, si spera, passi in fretta. Poiché, dunque, la Liturgia ha una sua dinamica, per collegarla alla vita quotidiana delle persone è meglio non ingombrarla di lungaggini: didascalie, introduzioni, continue monizioni o interventi.
- Un’altra riflessione fondamentale è sull’invito alla preghiera. Nella Celebrazione Eucaristica, come nella celebrazione degli altri sacramenti, al termine dei riti d’ingresso e prima della Liturgia della Parola il sacerdote dice: «Preghiamo». Anzitutto il significato della parola “colletta” (da colligere = raccogliere insieme, tenere uniti) indica appunto la raccolta delle preghiere che ciascun fedele ha formulato nel proprio cuore. Poi questa raccolta di preghiere viene espressa nell’unica preghiera (la colletta) pronunciata da colui che presiede la celebrazione. Infatti, la colletta è una delle tre orazioni presidenziali all’interno della Messa, cioè quelle preghiere dette dal presidente; le altre due sono l’orazione sulle offerte e l’orazione dopo la comunione. L’invito «Preghiamo!» non è una semplice formula di cortesia, ma ha due scopi ben precisi: dire che la preghiera che si fa è quella di tutta l’assemblea, anche se è il solo presidente che la pronuncia rivolgendola al Signore; invitare i membri dell’assemblea a pregare. Ma come si può pregare se appena rivolto l’invito viene subito proclamato il testo, senza alcuna pausa di silenzio? L’OGMR al n°54 precisa: «Il sacerdote invita il popolo a pregare e tutti insieme con lui stanno per qualche momento in silenzio, per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e poter formulare nel cuore le proprie intenzioni di preghiera. Quindi il sacerdote dice l’orazione, chiamata comunemente “colletta”, per mezzo della quale viene espresso il carattere della celebrazione».
- La Prima Lettura e il Salmo mettono in rilievo l’importanza dei gesti che esprimono gli atteggiamenti del cuore (“levare le mani”, “alzare gli occhi”). E’ l’occasione per vivere la celebrazione con tutto il corpo. Senza cercare o, peggio, inventare cose strane, basterà dare risalto all’atto penitenziale, al Padre nostro (le mani alzate; attenzione: è del tutto ingiustificata la prassi di tenersi per mano, inculcata persino da alcuni presbiteri, come espressione della fraternità! Nessuna fonte liturgica ci consegna questo atteggiamento. Non è affatto corretto incentivare questa modalità, in uso specialmente nelle Celebrazioni con i fanciulli ed i ragazzi!!!), al momento della Comunione (la mano tesa, come quella di un povero, per ricevere “il dono di Dio”).
- Paolo invita il suo discepolo Timoteo a proclamare la Parola. Oggi il ruolo della Parola nella Liturgia merita, dunque, di essere particolarmente evidenziato. Come? Nella processione di ingresso: il diacono o un altro ministro recheranno l’Evangeliario (anche qui molta attenzione: non il Lezionario!!!), che verrà intronizzato solennemente; al momento della proclamazione del Vangelo due ministranti si porranno con i ceri accesi accanto all’ambone e il libro verrà di nuovo incensato.
- Oggi in comunione con tutta la Chiesa celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale. Siamo invitati a rinnovare lo slancio missionario e a pregare per i missionari che sostengono l’opera di evangelizzazione per tutti i popoli della terra. La preghiera sia davvero universale e tenga conto delle Comunità cristiane ancora perseguitate a causa della fede. Nessuno di noi può rimanere tranquillo fino a quando il Vangelo non avrà raggiunto ogni realtà umana. Dovremmo fare in modo di poter distribuire ai fedeli il testo completo del messaggio del Santo Padre Francesco (uno dei suoi ultimi scritti).
- Questa Domenica è dedicata dalle Pontificie Opere Missionarie alla raccolta di offerte per sostenere il lavoro dei missionari. La raccolta delle offerte per sostenere l’impegno missionario della Chiesa, sia vista come un atto di culto, come sempre in ogni Messa: un po’ della mia vita per la vita dei fratelli. Questo gesto nasce dal Vangelo che lo rende vero.
- Si può celebrare oggi (ma meglio durante la settimana!) la Messa “Per l’evangelizzazione dei popoli”, secondo i formulari del Messale Romano. Si mantengano, però, le Lezioni bibliche della Domenica corrente.
- Si abbia particolare attenzione, nella celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, di non mettere in ombra la Liturgia odierna, così come purtroppo si è soliti fare! Una precisazione merita la formulazione delle intenzioni della Preghiera universale: la Parola ascoltata (Letture), meditata e attualizzata (omelia), si fa preghiera. Non è possibile pensare a delle intenzioni solo per le missioni e i missionari! Per una valida celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale si prevedano, pertanto, altri momenti fuori della Messa. Per esempio, una mostra missionaria, con proposte di impegno per ragazzi, giovani e famiglie, può risvegliare l’interesse di tutti nell’obbedire al comando del Signore: «Andate e fate mie discepole tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».
TESTI E MATERIALI
RITI DI INTRODUZIONE E DI CONCLUSIONE
** Suggerimenti Suggerimenti XXIX TO C
** Riti di Introduzione con Atto penitenziale XXIX TO C Riti introduzione
** Riti di conclusione XXIX TO C Riti di conclusione
SALMO RESPONSORIALE
** prima proposta, da Psallite
partitura Salmo XXIX TOC Psallite
audio
** seconda proposta, da Lodate Dio Salmo XXIX TO C LD
** terza proposta, dal m° Impagliatelli
partitura Salmo XXIX TO C Impagliatelli
audio
PREGHIERA DEI FEDELI
** prima proposta XXIX TO C Pdf 1
** seconda proposta XXIX TO C Pdf 2
** terza proposta XXIX TO C Pdf 3
** quarta proposta, in forma litanica/breve XXIX TO C Pdf 4
** da Orazionale CEI Pdf TO XXIX OR CEI