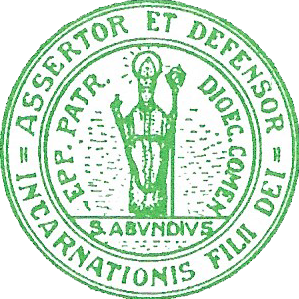III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C
«Proclamare l’anno di grazia del Signore»
VI Domenica della Parola di Dio
Tema: «Spero nella tua Parola» (Sal 119,74)
- Non si dà fede senza ascolto; tuttavia, la Parola che il Signore dona necessita di essere accolta, perché possa fecondare il cuore di chi l’accoglie. L’uomo non può nutrirsi di solo pane materiale; la parola che esce dalla bocca di Dio si fa carne nella pienezza dei tempi.
- La terza Domenica del Tempo Ordinario pone al centro della nostra riflessione Cristo Gesù impegnato a portare la speranza nel cuore degli uomini, a dare il conforto, a risollevare i deboli e i bisognosi, a venire incontro alle varie necessità umane e spirituali delle persone che egli incontra lungo il suo itinerario missionario. E’ il Dio vicino alle sofferenze dell’uomo e che non abbandona l’uomo nella sua condizione di bisogno, di malattia e solitudine, né lo lascia nella sua condizione di peccatore. Egli viene a proclamare l’anno giubilare, l’anno della misericordia di Dio e quanti vogliono accogliere questo messaggio di liberazione sperimentano la gioia di un incontro nell’amore e del perdono.
- Al centro di questa Pasqua domenicale c’è la Parola di Dio. Questa Parola, proclamata e ascoltata con grande venerazione dal popolo ebraico, si compie in Cristo. Egli è il Verbo eterno del Padre, la Parola fatta carne, attraverso la quale il Padre ha rivelato tutto sé stesso. A Nazaret, infatti, Gesù apre il libro di Isaia, legge il passo che riguarda la sua missione e lo applica a sé. Questo gesto ci introduce al significato profondo del mistero liturgico: Cristo «è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura» (SC 7a). Il protagonista è lui. È lui che ci convoca e presiede il nostro incontro, è lui che ci parla per primo, è lui che spezza il pane per noi, è lui che ci unisce in un corpo solo, è lui che ci manda a testimoniare.
- Il Dio di Abramo, di Isacco, di Gesù Cristo non è un Dio imposto, non è un Dio che si rivela nei fenomeni naturali ma, nella storia degli uomini, si rivela e si comunica in modo perfetto e definitivo nell’uomo Gesù. La Bibbia è la letteratura di un popolo: in essa sono raccolte le vicende, le sofferenze, le angosce, le gioie e le speranze della storia di un popolo; le riflessioni dei saggi, le liriche, gli inni dei poeti, le canzoni popolari fino alla vita delle primitive Comunità cristiane. Tutto questo è certamente “rivelazione dell’uomo”, ma è insieme “rivelazione di Dio”. La storia passata è letta come Parola di Dio perché alla sua luce possiamo leggere la nostra storia, la nostra vita, e scoprire e incontrare Dio nelle vicende del nostro quotidiano.
- La parola di Dio, però, lungi dall’alienare l’uomo, intende promuovere una fedeltà radicale alla condizione umana. La Prima Lettura ci manifesta il rapporto fra la parola di Dio qual è contenuta nella Bibbia e la Comunità. Il gesto di Neemia ci dice che il popolo di Dio per ricostruirsi dopo lo sfacelo dell’esilio ricerca la sua più profonda identità e unità nella parola di Dio. Anche oggi (e sempre) la Chiesa ritrova la sua identità nella parola di Dio. Senza la parola di Dio la Chiesa è “nulla”. La Chiesa è sempre in religioso ascolto della parola di Dio: da questa viene adunata e ne dipende totalmente; da essa deve lasciarsi continuamente “giudicare” e contestare. D’altra parte, la parola di Dio risuona in tutta la sua verità solo nella stessa Chiesa-Madre; e la sua ragione d’essere è nell’annunciare questa parola e nel testimoniarla come fedele discepola di Cristo, pienezza di tutta la rivelazione.
- Pertanto, la Chiesa non proclama un’astratta ideologia umana, ma la Parola che si è fatta carne in Cristo, Figlio di Dio, maestro e redentore di tutti gli uomini. Il Cristo capo della Chiesa (Seconda Lettura) è il Cristo-maestro, il Cristo-Parola (Vangelo). E’ lui che unifica la molteplicità e diversità delle membra in un solo corpo; è lui che unendo con la sua parola viva le menti e i cuori crea l’unità della fede.
- La lettura evangelica ci rivela l’attualità della Parola di Dio e il modo cristiano di leggerla. «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». (Lc 4,21). Ogni pagina del Vangelo non è parola morta ma viva che Dio dice a noi e che si realizza “oggi”. Il Vangelo non racconta solo la vita di Gesù, ma anche la mia vita. Il Vangelo ci contiene, ci coinvolge. Per questo la Liturgia della Parola non è una semplice lezione morale, né l’affermazione della speranza escatologica tenuta desta dai profeti; essa proclama l’adempimento del disegno del Padre nell’oggi della vita e dell’assemblea. Non si contempla qui un passato tramontato, né si sogna un avvenire straordinario, ma si vive il tempo presente come luogo privilegiato della venuta del Signore. Quindi non si cerca di applicare questo o quell’altro testo ispirato agli avvenimenti vissuti dai membri dell’assemblea, ma di indicare che l’evento vissuto oggi dagli uomini e dai cristiani rivela il disegno di Dio che si realizza in Cristo.
- Antico e Nuovo Testamento vengono resi attuali, vicini, se non si rimane attaccati alla lettera morta. In ogni pagina scopriremo presto o tardi di poter dire: “Qui si parla di noi. Io sono Adamo. Noi siamo gli apostoli sul mare. Noi ci troviamo precisamente come Gesù sulla via del Calvario e della risurrezione”. In tal modo, mediante la parola di Dio, noi veniamo lentamente a scoprire qual è la nostra vita agli occhi di Lui, vale a dire nella sua dimensione profonda.
- La parola che viene da Dio, di Dio possiede la potenza e l’efficacia. Essa interroga, provoca, consola, crea comunione e salva, sia pure in modo diverso, secondo i momenti e le forme; ogni atto di predicazione è glorificazione di Dio ed evento per l’uomo. Per questo è bene che ci poniamo seriamente alcune domande: Cristo entra ancora nelle nostre assemblee con la sua “Parola” che è letta, spiegata e compresa? Da questo triplice processo che coinvolge l’orecchio e il cuore sbocciano quei due atteggiamenti apparentemente antitetici, ma in realtà complementari, che caratterizzano l’assemblea radunata attorno a Esdra? Affiorano ai nostri occhi le lacrime della conversione (Ne 8,9), segno vivo del pentimento, mentre le nostre labbra si aprono al sorriso, perché, come ci ricorda il governatore Neemia, l’ultima parola di Dio non è mai quella del giudizio bensì la promessa del perdono (Ne 8,10)? Speriamo!
- Oggi iniziamo la lettura semi-continua del Vangelo secondo Luca, che ci accompagnerà per tutto l’anno “C”. Sarebbe auspicabile nella settimana che precede o segue questa Domenica programmare un incontro di catechesi in cui presentare il “terzo” Vangelo. Il Lezionario fa precedere la prima predicazione pubblica di Gesù con la presentazione che Luca fa della sua opera letteraria. Da un punto di vista artistico siamo di fronte al periodo letterario ideale di tutto il Nuovo Testamento che nulla ha da invidiare alle più pure pagine della letteratura greca classica. Questi primi versetti ci aiutano a percepire il canone storiografico adottato da Luca; qui si parala infatti dello scopo, del contenuto, delle fonti e del metodo di ricerca e composizione. Dal punto di vista sinottico, confrontando il prologo lucano con quello degli altri evangelisti, si coglie subito la sua singolarità. Mentre Marco (1,1) ci da un prologo da catechista, nel senso che egli, fin dall’inizio del suo Vangelo, si preoccupa di darci la sintesi della sua cristologia proprio per una intenzione di ordine catechetico; Matteo (1,1-17) ci da un prologo da scriba, nel senso che, aperto alla sensibilità giudaica dei suoi destinatari, egli si preoccupa di far risaltare fin dall’inizio i molteplici rapporti che legano Gesù al popolo giudaico; e Giovanni (1,1-18) ci da un prologo da teologo, nel senso che l’inizio del suo Vangelo si caratterizza proprio per una acutissima e profondissima riflessione teologica circa i rapporti di Gesù di Nazareth con il Padre. Luca, invece, ci da un prologo da storico, nel senso che egli si preoccupa di collegare esplicitamente l’evento “Gesù di Nazareth” con la “diakonia” dei suoi evangelizzatori. Il tempo di Gesù e quello della Chiesa formano una visione unitaria della Storia della Salvezza che prelude alla scelta tipicamente lucana di far seguire al racconto del vangelo di Gesù la narrazione della storia della Chiesa nascente.
- Non può mancare assolutamente oggi l’uso del Libro dei Vangeli nella processione introitale (Cristo-viene) e, accompagnato dai ceri, durante la proclamazione della pericope evangelica (Cristo-presente). Si scelga anche un adeguato canto per l’acclamazione al Vangelo, un canto che accompagni la “solennità” di questo momento.
- Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis”, Papa Francesco ha stabilito che “la III Domenica del Tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. Il documento è stato pubblicato il 30 Settembre 2019, nella memoria liturgica di San Girolamo, all’inizio del 1600° anniversario della morte del celebre traduttore della Bibbia in latino che affermava: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Mentre nei vari momenti della Celebrazione Eucaristica odierna, soprattutto nell’omelia, sarà bene sottolineare la centralità della Parola di Dio nella vita del cristiano e della Chiesa, si abbia cura di non trasformare la stessa celebrazione in una catechesi su tale tema.
- Un gesto molto semplice potrebbe sottolineare oggi la centralità della Parola di Dio… è quello della processione con l’Evangeliario, accompagnato dai ceri e dall’incenso, nella processione introitale e, quindi, prima della proclamazione della pericope evangelica. Attenzione: non il Lezionario, ma l’Evangeliario!!! E si faccia attenzione anche alla verità dei segni: non va bene neanche un Lezionario ricoperto magari con una copertina solenne o, peggio, una Bibbia!!! Se non vi è l’Evangeliario, con semplicità e con onestà, si potrebbe oggi portare il Lezionario in processione, prima della Prima Lettura, lungo la navata della Chiesa mentre si esegue un canto di introduzione alla Liturgia della Parola. Potrebbe essere lo stesso Presbitero/presidente che si reca in fondo all’aula liturgica dove è stato preparato e che lo porta mentre si esegue il canto (senza ceri e senza incenso!!!); giunto nel presbiterio, lo pone all’ambone e il lettore, come di consueto, proclama la Prima Lettura, mentre tutti siedono. Attenzione: è solo e semplicemente un’idea… non una regola liturgica! Nei suggerimenti dei canti, appena sotto, trovate anche delle proposte per l’inizio della Liturgia della Parola… se si sceglie di farlo, potrebbe bastare anche un ritornello, in modo da non appesantire la Celebrazione.
- Si può pensare di sottolineare oggi lo spazio dell’ambone illuminandolo adeguatamente e ornandolo sobriamente con fiori, ricordando che esso è monumentum resurrectionis, luogo dal quale la Chiesa sempre annuncia il Vivente che raduna e parla al suo popolo.
TESTI E MATERIALI
RITI DI INTRODUZIONE E DI CONCLUSIONE
** Suggerimenti Suggerimenti III TO C
** Riti di Introduzione con Atto penitenziale III TO C Riti introduzione
** Riti di conclusione III TO C Riti conclusione
SALMO RESPONSORIALE
** prima proposta, da Psallite
partitura Salmo III TO C Psallite Pantaleo
audio
** seconda proposta, da Lodate Dio
** terza proposta, dal m° Impagliatelli
partitura Salmo III TO C Impagliatelli
audio
PREGHIERA DEI FEDELI
** prima proposta III TO C PDf 1
** seconda proposta III TO C Pdf 2
** terza proposta III TO C Pdf 3
** da Orazionale CEI Pdf TO III OR CEI